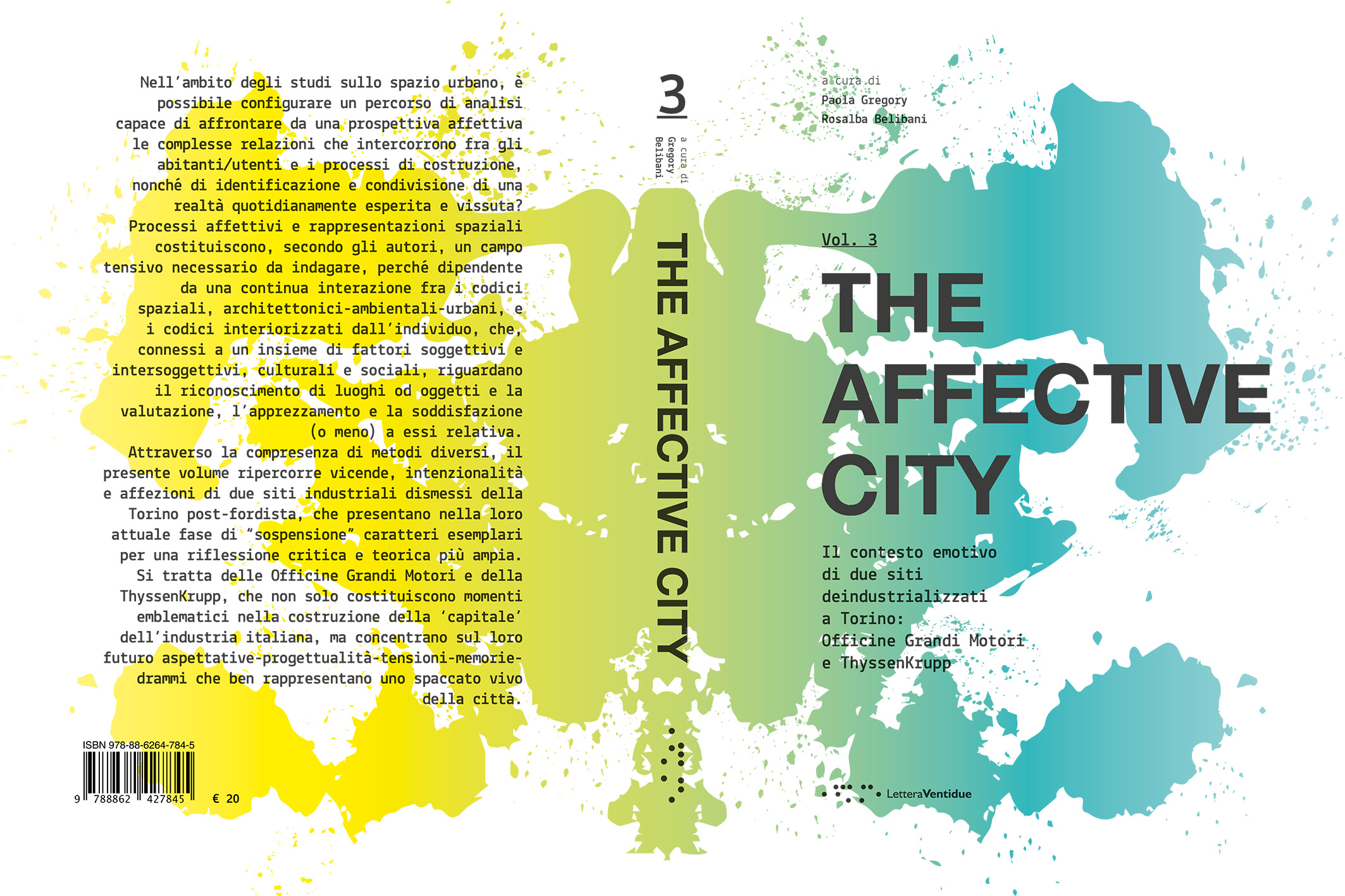- Dettagli
- Categoria: Pubblicazioni
Partendo dalla svolta emozionale che nella nostra epoca caratterizza la comprensione della realtà, il volume ripercorre alcuni nuclei tematici del pensiero estetico, filosofico e neuroscientifico che hanno categorizzato l’empatia come modo fondamentale della relazione con l’alterità.
All’interno di quest’ultima si colloca anche il nostro rapporto con gli oggetti e con gli spazi che abitiamo, nel quale le risposte affettive precedono qualsiasi interpretazione riflessiva. Tuttavia l’empatia, coinvolgendo nella relazione con l’altra o con l’altro la nostra stessa esistenza, tiene insieme emozione, cognizione e comportamento, indicando anche una postura etica e sociale che può favorire nel progetto architettonico una risposta maggiormente orientata alla condivisione consapevole e all’inclusione dell’alterità. In questo orizzonte di riferimento rientrano quelle ricerche che aprono a una concettualizzazione “patica”, non priva di potenzialità critiche, dello spazio abitato, ripensato come medium incorporato della nostra esperienza vissuta. Di qui l’interesse per un’architettura multisensoriale, multidimensionale, interattiva e sinestetica, capace di esaltare nell’essenza relazionale dell’architettura il nostro “corpo coinvolto”, ovvero il modo poetico in cui ci confrontiamo e sintonizziamo fra noi e con il mondo-ambiente.
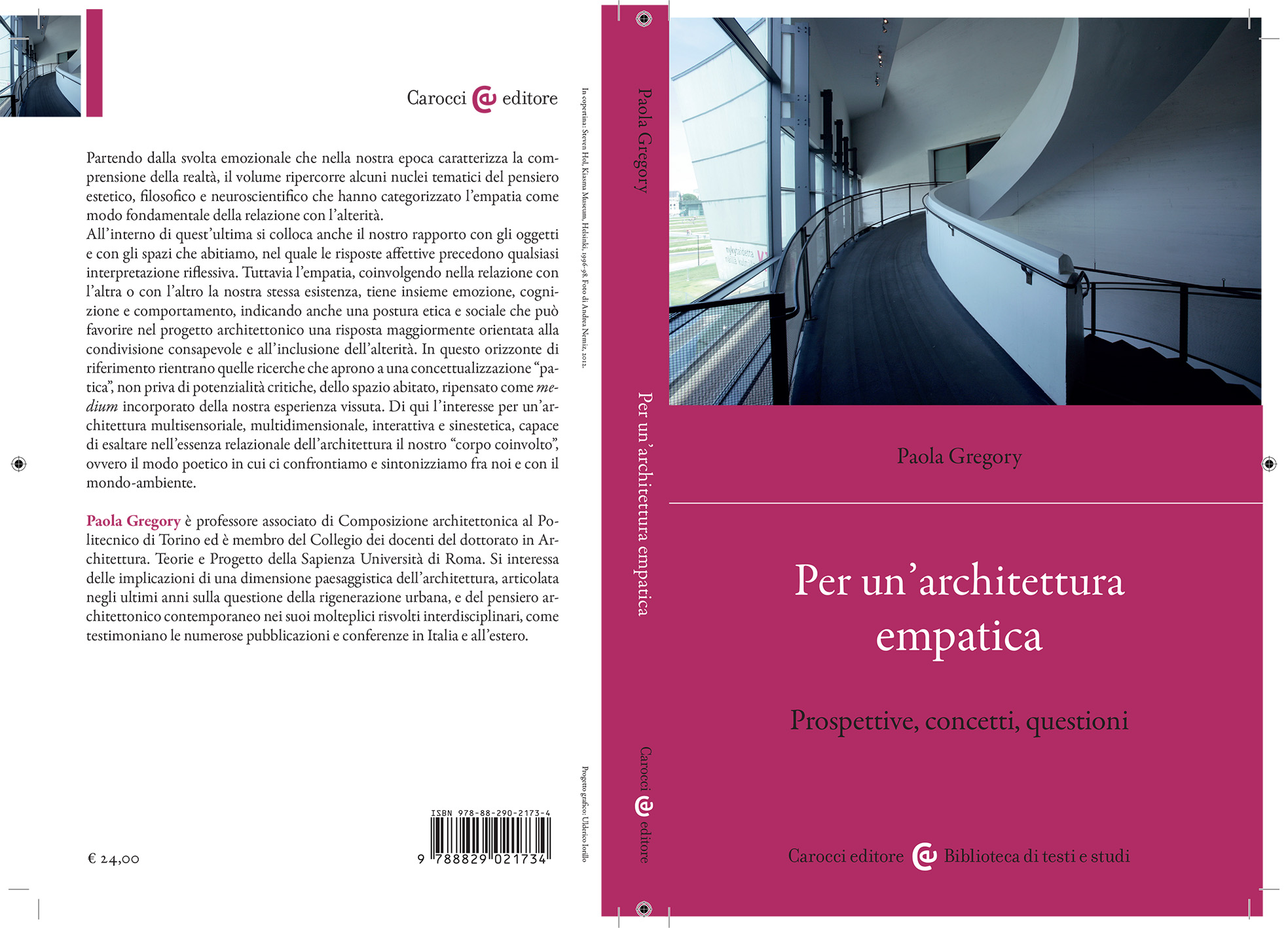
- Dettagli
- Categoria: Pubblicazioni
Dal testo Experiencing architecture di Rasmussen a Questions of perception di Holl, Pallasmaa e Pérez-Gomez, fino al recente libro di Mallgrave From Object to experience, la condizione empatica e affettiva è divenuta sempre più centrale nella riflessione sull’architettura. Il saggio ripercorre alcuni momenti salienti dello sviluppo dell’empatia nella critica estetica e nella filosofia fenomenologica, sottolineando i fattori culturali e scientifici che hanno recentemente contribuito a ciò che è stato definito emotional turn. Particolare evidenza viene data agli sviluppi, dagli anni’80 in poi, dell’embodied cognition e al modello percettivo dell’embodied simulation che, a seguito della scoperta dei mirron neurons, può costituire oggi la base funzionale dell’empatia: quell’affective empathy alla quale dobbiamo, tuttavia, affiancare una reconstructive empathy, che, partendo dai vissuti del percipiente, richiede attenzione, immaginazione e memoria. In questa convergenza fra scienze della natura (con particolare attenzione alle scienze cognitive e alle neuroscienze) e scienze umane, l’architettura può riguadagnare una dimensione – di tradizione fenomenologica – legata al corpo-vivo, in cui la riscoperta dell’empatia diviene possibilità di declinare una comprensione dello spazio (tanto nell’uso, quanto nel progetto) che ha nel sentire e nell’agire umano il suo fulcro.
- Dettagli
- Categoria: Pubblicazioni
- Dettagli
- Categoria: Pubblicazioni